«Lo Smeraldo». Una rivista tra cultura, letteratura e impresa (1947-1965)
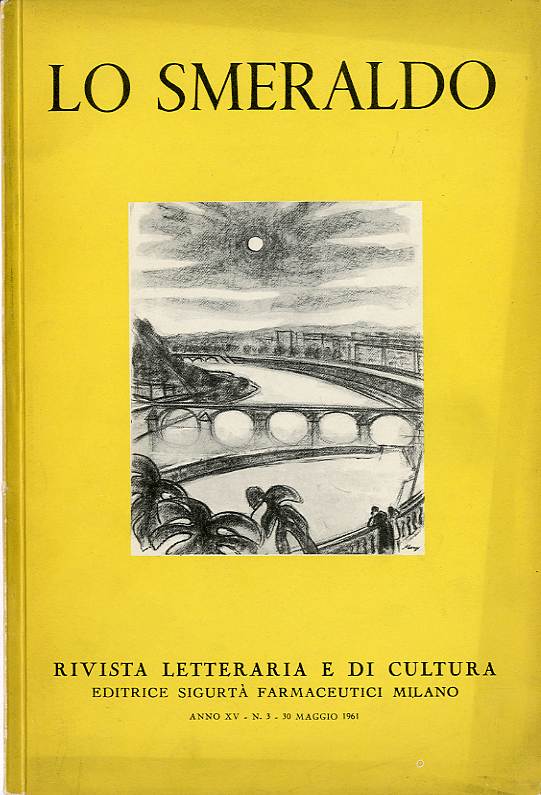
“Lo Smeraldo”, periodico di cultura e letteratura fondato da Giuseppe Carlo Sigurtà nel 1947 per celebrare il ventesimo anniversario della sua azienda farmaceutica
Nel panorama culturale italiano del secondo dopoguerra, la rivista «Lo Smeraldo. Rivista letteraria e di cultura» occupa un posto particolare: non è soltanto una vetrina per le voci più autorevoli del tempo, ma anche uno dei primi esperimenti riusciti di connessione tra impresa e promozione culturale. Pubblicata con cadenza bimestrale dal 1947 al 1965, «Lo Smeraldo» è finanziata dalla casa farmaceutica Sigurtà, che la utilizza come strumento di comunicazione aziendale, senza però rinunciare a una solida impostazione letteraria e intellettuale. L’idea di fondare «Lo Smeraldo» nasce proprio dall’industriale Carlo Sigurtà: è lui stesso a immaginare una rivista che, pur nascendo in ambito commerciale – lo testimonia una lettera indirizzata a Giovanni Comisso: «ai medici appunto è dedicata la nostra rivista» –, possa porsi come “ponte” fra scienza, arte e letteratura. In questo senso, «Lo Smeraldo» rappresenta un esempio precoce e riuscito di marketing culturale ante litteram: all’interno dei fascicoli sono talvolta inclusi allegati scientifici al fine di promuovere determinati prodotti, ma questo avviene senza mai compromettere il valore culturale della pubblicazione.
Il primo direttore della rivista è Eugenio Bertuetti (1895-1964), originario di Sopraponte di Gavardo (Brescia), giornalista e scrittore. Trasferitosi a Torino, Bertuetti riesce, nel difficile contesto del dopoguerra, a dare vita a un progetto editoriale raffinato e coerente, che accoglie racconti, poesie, prose di viaggio, ritratti letterari, saggi brevi e articoli critici. Egli stesso firma numerosi testi, contribuendo in prima persona. La sua direzione, protrattasi fino al 1964, si affianca a un’intensa attività in ambito radiotelevisivo: dal 1953 Bertuetti lavora per la Rai, fino a ricoprire il ruolo di direttore del settimanale «Radiocorriere TV». Nel 1952, passa il testimone a Dario Cartago Scattaglia, già caporedattore e stretto collaboratore di Bertuetti. Anche Cartago Scattaglia contribuisce attivamente con testi critici e prose originali, e riesce a mantenere alta la qualità editoriale. La rivista continua la sua attività fino alla morte improvvisa del direttore, avvenuta nel 1965: l’ultimo numero, il quinto, esce con data 30 settembre quell’anno sancendo la chiusura definitiva del progetto. Il 12 marzo 1964, in una lettera indirizzata a Enrico Falqui, Cartago Scattaglia comunica con tono sommesso e personale la morte improvvisa di Bertuetti: «ci ha lasciati stamane, dopo una malattia di pochi giorni; grave sì, ma che non faceva prevedere una soluzione così triste e così immediata. Il vuoto che lascia è grandissimo; e pari la tristezza. Ella sa certo comprendere l’uno e l’altra».
Peculiarità dello «Smeraldo» è la cura per la componente visiva, che si riflette non solo nell’attenzione alle copertine, affidate a importanti artisti del Novecento italiano, tra cui Giorgio de Chirico, Carlo Carrà, Filippo de Pisis, Achille Funi, Arturo Martini, Giuseppe Novello e Mario Vellani Marchi, ma anche nella presenza di inseriti fotografici – talvolta a colori –, in “dialogo” con il contenuto dei testi. Ogni fascicolo, riconoscibile per la sua sobria eleganza, mantiene il medesimo formato: 32 pagine, copertina gialla, immagine in bianco e nero incorniciata al centro. Fra questi fogli, collaborazioni di altissimo profilo: tra i nomi più noti figurano quelli di Eugenio Montale, Umberto Saba, Giuseppe Ungaretti, Alberto Moravia, Giovanni Comisso, Giovanni Papini, Achille Campanile, Dino Buzzati, Enrico Falqui, Gianna Manzini, Anna Maria Ortese, Michele Prisco. Accanto ai letterati, vi sono firme di critici come quella di Massimo Mila che nel 1955 scrive a Bertuetti: «Sempre al bando dal “Radiocorriere”, penso che non mi sia invece chiusa la sua rivista personale, e mi faccio vivo con questo articolo». Il clima culturale che ruota attorno allo «Smeraldo» è anche occasione di incontri memorabili, come quello tra Bertuetti e il Premio Nobel Alexander Fleming, ospite della famiglia Sigurtà nella villa di Valeggio sul Mincio: a testimonianza dell’evento restano le parole di Indro Montanelli, che ne racconta l’atmosfera unica.
Oggi, l’intero archivio della rivista è conservato presso APICE. Si tratta di un patrimonio documentario di grande valore: oltre 1600 lettere di corrispondenti italiani e stranieri, tra cui molti degli scrittori che collaborano con la rivista. Fra i carteggi più ricchi, spiccano quelli con Comisso, Marino Moretti e Maria Luisa Spaziani. Bertuetti, in una lettera indirizzata proprio a Moretti nel dicembre 1954, scrive: «Ho poi ricevuto anche la novella inedita, la quarantanovesima, per “Smeraldo”. È molto bella, c’è dentro un Moretti specchiato, terso, ma è lunga, molto lunga. Abbia ad ogni modo la bontà di lasciarmela ugualmente, perché mi capiterà sempre uno “Smeraldo”, magro di varietà, che richieda una lunga composizione novellistica». Altre 500 lettere documentano invece il dialogo costante tra Bertuetti e Cartago Scattaglia, testimoniando le dinamiche redazionali e le scelte editoriali nel corso degli anni. Ma sono conservati pure documenti amministrativi e numerosi dattiloscritti annotati.
In questo contesto emergono le relazioni di fiducia tra redattori e autori. Michele Prisco, da parte sua, invia racconti inediti e accetta con comprensione i tempi redazionali, mentre Anna Maria Ortese scrive nel 1962 una lettera accorata in cui confessa: «Ho grande urgenza del compenso relativo alla collaborazione. […]. Lei è stato sempre così gentile, dimostrando una stima o valutazione personale delle mie cose: stima e valutazione che altrove sono considerate uno spreco. Così, anche per questo, in Lei io ho fiducia». Bertuetti si rivolge affettuosamente a Paolo Monelli per invitarlo a scrivere un testo sulla città di Bologna – «“Smeraldo” pubblica da tempo interpretazioni di città (Roma: Baldini; Napoli: Rea; Venezia: Valeri; Firenze: Caprin; Milano: Vergani; ecc…) e mi piacerebbe una interpretazione di Bologna scritta da te» –, ricordandogli scherzosamente: «Un giorno mi hai detto che per “Smeraldo” avresti scritto volentieri purché ti pagassi il doppio degli altri. Ora, io sono un po’ fuori dai mercati sontuosi dell’attuale giornalismo e quindi non so se la mia offerta è tale da invogliarti o meno. Comunque la faccenda è trattabile purché tu mi accontenti». Lo stesso tono confidenziale emerge nelle corrispondenze con Michele Serra e Angelo Romanò, che riconoscono alla rivista «serietà e dignità» e si dichiarano felici di collaborare. Non stupisce, dunque, che in una lettera del 1950 indirizzata dal direttore ad Arnoldo Mondadori si apprenda che «Francesco Pastonchi riferisce ch’Ella desidera avere in visione alcuni numeri de “Lo Smeraldo”. Mi affretto a farglieli spedire nella speranza che Le piacciano. Mi è gradita l’occasione per ringraziarla dell’interessamento e inviarLe i sensi della più profonda considerazione».
Un’ulteriore testimonianza del posizionamento editoriale e della portata della rivista si trova in una lettera che Eugenio Bertuetti indirizza a Leone Piccioni nel gennaio 1961. In essa, Bertuetti annuncia con tono quasi liberatorio la fine della sua collaborazione con il «Radiocorriere» – «Radiocorriere consummatum est, per me» –, manifestando il desiderio di tornare a occuparsi con maggiore attenzione della sua «vecchia rivista», «Lo Smeraldo», che ammette di aver «un tantino trascurata». La lettera non solo ha valore informativo, ma si presenta come un appello alla collaborazione, fondato su una stima sincera: Bertuetti riconosce in Piccioni una delle voci critiche più sensibili del panorama letterario italiano – «Io sono fra coloro che seguono attentamente le Sue prose, che ne conoscono il valore e l’amore» – e lo invita a scrivere due ritratti, dedicati a Cecchi e Ungaretti, per un numero in uscita a marzo. Nel tentativo di convincerlo, delinea anche il pubblico di riferimento: «è composto molto da medici, ma lei sa che intorno ai medici e ai loro salottini passano persone d’ogni grado». Un’argomentazione strategica che mira a rassicurare l’interlocutore sulla serietà dello «Smeraldo» nonostante la sua provenienza “industriale”. La rivista – sottolinea Bertuetti – ha una tiratura di oltre 45.000 copie, ma non per questo ha mai rinunciato a rigore e qualità; conclude poi offrendo un compenso di centomila lire e confidando in una «risposta affermativa», che possa dare nuovo slancio a un progetto che considera ancora vivo e degno di attenzione: «Vi scrivono Valgimigli e Valeri, Moretti e Comisso, Gianna Manzini e Ravegnani, Marco Valsecchi e altri. Vi hanno scritto Gadda, De Robertis, Ungaretti, Angioletti, Falqui. Voglio dire che è cosa seria, anche se, come dicevo, l’ho lasciata un po’ andare, mentre mi piacerebbe rimetterla in sesto».
«Lo Smeraldo», nella sua breve ma intensa parabola, rappresenta dunque un esempio significativo di come cultura e impresa possano dialogare senza compromessi, offrendo al lettore un prodotto editoriale capace di coniugare qualità e visione innovativa. Una voce elegante, oggi in gran parte dimenticata, che racconta lo spirito di un’epoca in cui la cultura era ancora considerata un bene comune e un investimento sul futuro.
Elena Grazioli
Università degli Studi di Milano
